(DOWNLOAD) "Bibbia Traduzione Letterale: Geremia" by Fabrizio Bartolomucci * Book PDF Kindle ePub Free
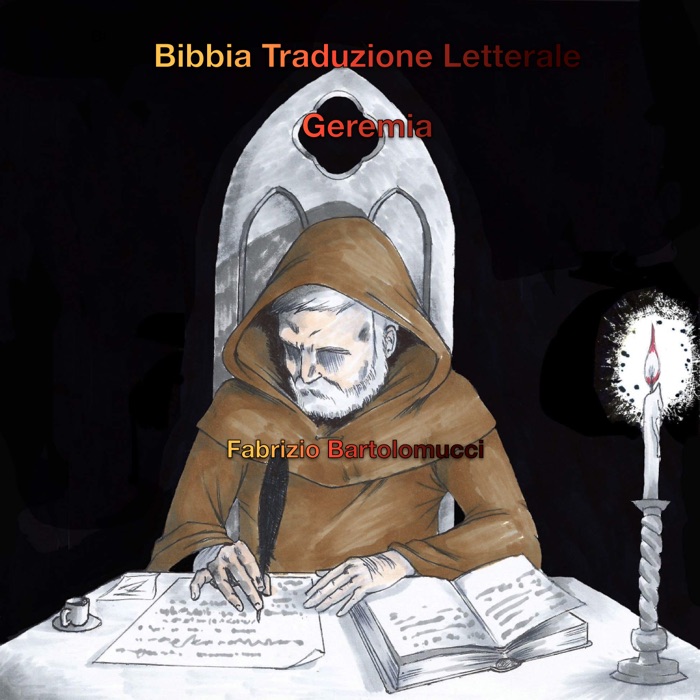
eBook details
- Title: Bibbia Traduzione Letterale: Geremia
- Author : Fabrizio Bartolomucci
- Release Date : January 05, 2018
- Genre: Bible Studies,Books,Religion & Spirituality,
- Pages : * pages
- Size : 17131 KB
Description
Caso quasi unico nella letteratura mondiale, la Bibbia non è mai riuscita a separare la fase della traduzione da quella dell’interpretazione. Probabilmente per l’ambiguità e per la mutabilità del contenuto, da sempre i traduttori hanno provveduto a inserire la loro interpretazione del testo spacciandola per autentica, non disturbandosi di riportare le proprie scelte interpretative, ma piuttosto aggiungendo note che allontanano ancora di più il significato dal testo originale: è caratteristica in ambito cristiano l’iniezione di contenuti del nuovo testamento o addirittura di speculazione teologiche successive come lo spirito santo o le profezie. In questa opera, seguendo le indicazioni di Mauro Biglino, provvediamo invece a tradurre la Bibbia letteralmente, annotando quando si sono fatte scelte diverse: per ‘Ĕ·lō·hîm, e benedire. La struttura di base del testo, per quanto riguarda le parti standard, viene dal portale laparola.net, mentre i contenuti letterali, integrazioni ed emendamenti al testo attingono alla Bibbia interlineare su Biblehub.com. La regola generale per i termini non standard è che, ove una parola ebraica è presente in una singola istanza, oppure in parti diverse con significati diversi, o ancora nel caso che una qualsiasi traduzione potrebbe introdurre nel lettore un bias indesiderato, la decisione è quella di lasciare la parola nell’originale fonetico. Questo è il caso ad esempio di: ‘Ĕ·lō·hîm, Yah·weh, Šad·day, ‘El·yō·wn, Rū·aḥ, Kā·ḇō·wḏ, Mal·’aḵ.
Le persone di nomi, aggettivi e verbi seguono scrupolosamente l’originale ebraico, anche riguardo termini controversi come ‘Ĕ·lō·hîm, Šad·day, ’Êl, senza risolvere arbitrariamente le contraddizioni. Il genere degli articoli e aggettivi resi in ebraico viene associato al genere del termine ebraico, e non a quello di una delle traduzioni in italiano; questo può naturalmente portare a ulteriori discrepanze del testo rispetto le traduzioni clericali. Nel caso particolare di ‘ĕ·lō·hîm, quando preceduto da articolo determinativo, si è deciso di renderlo sempre come ‘gli ‘ĕ·lō·hîm’, anche quando il termine regge un verbo al singolare. La soluzione appare altrettanto insoddisfacente quanto coniugare l’articolo col verbo, in cui si usa l’aggettivo singolare solo con il verbo al singolare, in ‘l’‘ĕ·lō·hîm’, e in tutti gli alti casi al plurale, ma riteniamo la forma decisa preferibile dal punto di vista della leggibilità e obiettività.
Subito a Geremia 1: 16 si fa piazza pulita del concetto di male per Yah·weh che non ha nulla a che fa con qualsivoglia principio etico, ma riguarda esclusivamente l’abbandonare lui per seguire altri ‘ĕ·lō·hîm!
A Geremia 2: 28 un curioso e inedito caso del singolare ‘ĕ·lō·he coniugato con verbo al plurale.
In Geremia 3: 6 si continua a usare il termine prostituirsi per intendere il passare da un ‘ĕ·lō·he a un altro, come si fa da un uomo a un altro. Si è preferito lasciare la traduzione in Italiano, piuttosto che sostituire le parole ebraiche, sia per il numero molto ampio di parole con la radice זְנ֖ che avrebbe portato a un’estrema complessità nella resa fonetica non volendo in quest’opera ordinare le parole per radice, come fanno i dizionari ebraici per esperti, sia soprattutto per il fatto che la parola è polisemica anche nelle lingue occidentali.
A proposito del comandamento “non nominare il nome di Dio invano” si situa Geremia 4: 2 dove invece si incoraggia a giurare sulla sua vita...!
A Geremia 7: 18 appare il suggestivo riferimento alla Regina dei cieli, leggendo la quale il monoteista cristiano è portato a pensare sia una profezia per la madonna, che riceverà nel futuro lo stesso appellativo, naturalmente trascurando che qui si parla piuttosto di ‘Aš·tō·reṯ.
A volte si ha come la sensazione che i redattori del testo aspettino la superficialità dei lettori, o non leggono essi stessi con attenzione i libri precedenti, come in Geremia 7: 22 quando si fa dichiarare a Yah·weh che non ha dato disposizioni sugli olocausti e i sacrifici, quando gran parte del Levitico, e parte dei Numeri, oltre alla rievocazione del Deutoronomio sono dedicati proprio alle disposizioni riguardo gli olocausti e i sacrifici perché Yah·weh potesse odorare il suo regolare “soave profumo”!
In Geremia 7: 31 è presente una caratteristica scusatio non paetita, visto che i primogeniti che Yah·weh si faceva dare, tra tutti gli animali e i figli stessi degli Israeliti, non si sa che fine avessero fatto, considerando che non si sono mai visti tornare indietro e come egli apprezzasse il grasso bruciato!
Sembra una critica per gli idoli di pietra il fatto che non possano fare né bene né male in Geremia 10: 5, ma sembrerebbe andare ai loro seguaci di lusso rispetto le violenze poco dopo e nel resto del libro attribuite a Yah·weh nel confronto dei suoi...
A Geremia 10: 18 si afferma un curioso principio, che occorra affliggere la gente per fasi cercare, piuttosto che essere gentile con lei come sarebbe senso comune, almeno indoeuropeo.
Giacobbe 10: 25 è interessante per due ordini di motivi: il primo, evidente, e abbastanza umano, è la richiesta a Yah·weh di prendersela con gli altri, piuttosto che con se stesso, se se la deve prendere con qualcuno; il secondo è più interessante in quanto fa riferimento ai supposti soprusi subiti da Giacobbe, uno dei personaggi più infidi e perfidi della letteratura mondiale, di cui la Bibbia parla solo di soprusi e inganni fatti da lui, tanto ai suoi parenti che ai benefattori, e mai di subiti.
Probabilmente nessuno si cura di verificare le profezie, sempre nella forma di maledizioni contro i suoi nemici - mai che Geremia preveda qualche cosa di positivo - anche volendo interpretare l’aiuto di Yah·weh come grave malattia o caduta da cavallo del nemico, visto che di persona non si è più rivelato dopo il Pentateuco nonostante le invocazioni, in quanto a Geremia 11: 23 questi ne lancia una contro la gente di Anatòt che in nessuna parte della Bibbia viene detto essere colpita da alcunché; anzi viene regolarmente annoverata nell’armata di Yiś·rā·’êl.
Interessante a Geremia 14: 15-16 l’osservazione che per essere buoni nā·ḇî·îm occorre parlare di disgrazie; se invece si parla di salvezza ecco che incomba la punizione di Yah·weh; non si sa se questa osservazione sia causa o conseguenza del carattere menagramo di tutto il libro, ma certamente ci si accorda.
A Geremia 14: 22 un aspetto che i teologi sicuramente ascriveranno all’arretratezza del testo, pur considerando Geremia un profeta che parla infallibilmente per il resto! Resta comunque come punto ineliminabile il fatto che Geremia ascriva il potere di Yah·weh alla capacità di determinare il tempo meteorologico come base della sua potenza, non ad altro.
A Geremia 15: 13 una interessante ammissione attribuita a Yah·weh, quando minaccia gli Israeliti di farli loro servire altri ‘ĕ·lō·hîm escludendo con ciò il fatto che possano essere idoli di pietra e frutto della mano dell’uomo, come detto altrove.
A Geremia 16: 21 un esempio dove la traduzione monoteista per Yah·weh come Signore mostra la corda, quando si riporta l’enfatica di dichiarazione in cui questi afferma che il suo nome è Signore, ove l’ebraico riporta il molto più ragionevole nome personale.
A Geremia 17: 21 si ha una risposta al motivo per il quale i contemporanei ce l’avessero con Geremia; potrà pure non essere ascoltato, ma gente che ti maledice di continuo non penso faccia molto piacere ad alcuno.
A Geremia 19: 14 si colloca un aspetto che trovo di una comicità di tipo inglese. Per tutto il resto del capitolo ha mandato maledizioni a tutti e a tutto, e ci si sarebbe aspettati che tornando al suo paese avesse trovato gli effetti nefasti delle sue maledizioni, con case bruciate, cadaveri in giro in pasto agli animali selvatici e tutto quanto aveva ardentemente augurato, invece il culmine del capitolo è che ripete le sue maledizioni anche nel tempio di Yah·weh! dove peraltro questi non c’è , altrimenti ci parlerebbe direttamente, invece di parlare a suo nome.
Si può dire che in Geremia 20: 14 e segg. il nā·ḇî abbia decisamente perso la pazienza, vedendo l’inevitabile latitanza di Yah·weh, problema comune a tutti quanti si siano affidati a lui dopo la sua dipartita, se si eccettuano naturalmente eventi casuali positivi o negativi interpretati come un suo favore o sfavore, come si fa ancora oggi.
E naturalmente, appena se ne prospetta l’occasione in Geremia 21: 2, il traditore Geremia si schiera immediatamente per il nemico babilonese, allo scopo di avvalorare le sue parole precedenti; non mancando naturalmente di millantare ancora una volta la confidenza di Yah·weh. Naturalmente in una terra pericolosa e incerta come la Palestina, ora come allora, qualsiasi cosa si preveda, prima o poi avviene così da poterla attribuire a cosa si crede: dal caso, alla propria saggezza, all’intervento divino.
Andata bene con i Babilonesi, in Geremia 21: 14 questi ci riprova con gli incendi boschivi, altro evento ovviamente abbastanza frequente in quei tempi, aspettando pazientemente che se ne verifichi per poter cantar vittoria: ovviamente la patente che si darebbe oggigiorno a tale comportamento sarebbe quella di menagramo, ma Geremia figura piuttosto tra i grandi profeti delle tradizioni monoteiste. Un nuovo punto che dovrebbe dare da pensare.
A Geremia 23: 33 e segg. ricompare la curiosa parola polisemica maś·śā che diventa ancora più misteriosa come usata in questo capitolo. Il traduttore monoteista si tappa il naso e traduce consistentemente con ‘carico’.
A Geremia 28: 15-17 Geremia manifesta potente il suo potere di iettatore, ma in ciò facendo rende manifesto ancora una volta come il potere di Yah·weh si applichi come massimo in forma esclusiva alla vita su questa terra, magari facendola terminare bruscamente secondo le maledizioni di Geremia, mai a uno spazio alla morte successivo.
In generale tra i capitoli 26 e 29 si svolge una battaglia di potere tra Geremia e altri nā·ḇî·îm essenzialmente sulla previsione della durata dell’esilio in Babilonia per i quali ciò che tocca a chi soccombe è la morte. Geremia tende a prevalere con le sue previsioni peggiori di tutte quelle degli altri, forse alimentando o essendo frutto di un certo approccio culturale che favorisce la sofferenza alla speranza, o almeno quest’ultima riferita a un periodo oltre la propria stessa vita, per non doverne rispondere.
Ciò fatto salvo che, nei capitolo 30 e 31, una volta evidentemente eliminati i concorrenti, ecco che comincia lui a predire un prossimo ritorno di Yah·weh...
Significativo, nel novero delle cose che farà Yah·weh se e quando dovesse tornare c’è il passo a Geremia 31: 12, dove si chiarisce la natura assolutamente materiale di ciò che ci si aspetta da Yah·weh stesso.
A Geremia 31: 22 una frase davvero criptica e del tutto isolata dal contesto, quasi fosse stata inserita di proposito per farci trovare la profezia della Madonna ai teologi...
A Geremia 31: 28, se ancora non fosse stato bene chiaro, si precisa come sia sempre Yah·weh a fare il male, e molto più occasionalmente bene in termini materiali, mai il povero śā·ṯān, tradotto più o meno propriamente.
A Geremia 34: 10-11 si ripete lo schema: si prende la violazione di uno dei numerosi “Comandamenti”, ben più dei dieci canonici dati da Yah·weh, in questo caso la restituzione degli schiavi dopo sette anni, per attribuire a essi nuove distruzioni. Data la varietà delle disposizioni Geremia ha l’agio di attribuire qualsiasi distruzione imminente alla violazione del comandamento in quel momento non rispettato.
A Geremia 35 si ripete lo schema solo leggermente variato e con una interessante curiosità. Questa volta il comandamento in oggetto è quello di non bere vino, di cui peraltro non si parla affatto tra gli ordini originali di Yah·weh, essendo le libagioni parte fondamentale delle offerte rituali, e di vivere come nomadi, ugualmente assente da essi, questa volta con lo schema del confronto: si prende una famiglia che lo rispetta e si mette a confronto con quanti non lo fanno; schema simile a quanto si fa ordinariamente in una classe scolastica, auspicabilmente con una sorte più benevola che tocchi ai cattivi di quanto prospettato da Geremia... La cosa ancora più interessante è che il precetto di non bere alcol e di vivere in forma ambulante è parte delle pratiche ascetiche di altre tradizioni: in particolare di quelle indoeuropee del continente Indiano, peraltro coeve; non si può quindi escludere un prestito da parte di tali culture per dare contenuto a questo capitolo, altrimenti ingiustificabile sul piano dello stretto contenuto biblico.
Geremia 36 è, per così dire, ricorsivo: qui la causa a cui si attribuisce la distruzione del paese è la distruzione da parte del re di un documento che parla di quell’argomento. Oramai Geremia, evidentemente essendo avvertito dell’imminente venuta degli invasori, fa di tutto per ottenere da ciò il massimo prestigio, veramente utilizzando tutti i mezzi, anche al di là dei precetti, veri o inventati, dei capitoli precedenti.
Al capitolo 37 Geremia si lancia in una autodifesa davvero sorprendente; si domanda in che cosa abbia danneggiato il suo popolo per essersi semplicemente dedicato ad augurare la loro sconfitta e sofferenza! certo attribuendo la responsabilità a Yah·weh. Il re, per buona misura, lo tiene prigioniero, ma gli da da mangiare. Curioso peraltro come in questo capitolo Geremia sembri per la prima volta avere paura: prima provando a fuggire e poi implorando per la propria vita il re che aveva arrestato la fuga, mettendo per un poco da parte la spocchiosità precedente.
E naturalmente a Geremia 39: 11-14 Geremia viene ricompensato da Nabuconosor del tradimento fatto verso il popolo di Israele e di Giuda: del resto se Geremia e gli invasori non fossero stati in costante contatto, come avrebbero questi saputo del suo contributo e dell’attribuzione della cosa a Yah·weh. Il redattore biblico non batte ciglio, attribuendo naturalmente tutto al favore di Yah·weh nei confronti di Geremia millantato da Geremia stesso, rifiutandosi di vedere la sostanza del tutto, probabilmente attribuendo il passaggio di informazioni a Yah·weh stesso, che si trasformerebbe in una sorte di postino in questa occorrenza.
A Geremia 40: 5 si chiarisce la natura della corruzione quando, in aggiunta ad aver salda la vita e data la possibilità di vivere libero nel paese, il capo della guardie offre a Geremia persino una ricompensa, parola che il traduttore monoteista traduce piuttosto che con il moderno ‘tangente’ con ‘regalo’, provando a continuare a nascondere la sostanza della cosa.
Ottimista chi pensasse che il tradimento del popolo di Yiś·rā·’êl verso i Babilonesi lo acquietasse. Infatti a Geremia 42: 21-22 ricomincia prendendosela con chi desideri abbandonare gli stessi Babilonesi, maledendoli preventivamente, per buona misura. Devono averlo pagato davvero bene i Babilonesi per questa fedeltà.
In questo passo si rivela ancora più la posizione di spia di Geremia quando appare evidente in Geremia 42: 8 che questi ha seguito, probabilmente di nascosto, i Giudei nel viaggio in Egitto assai probabilmente per conto dei Babilonesi.
A Geremia 44: 13 una frase che sembra campata in aria; Giuda è capitolato per la rottura delle mura, non per l’assedio. Poi in questo caso, non trovandosi le nuove ‘vittime’ in una città fortificata, è assai poco probabile che muoiano di fame e pestilenza, quindi Geremia continua a giocare a caso, sperando che continuino a non vedere il bluff. Tuttavia la versione dell’episodio a Geremia 52: 5 sembra mettere una pezza alla faccenda.
A Geremia 43: 17 torna la Regina dei Cieli, assai probabilmente ‘Aš·tō·reṯ, che naturalmente i teologi travisano per la Madonna, trascurando ovviamente il contesto. Da notare la candida ammissione dei Giudei di come seguire lei portava motlo più fortuna che seguire Yah·weh. E come dar loro torto?!
Ora in Geremia 44: 30 si attribuisce l’ostilità di Yah·weh nei confronti degli Egiziani senza nemmeno sentire il bisogno di spiegare cosa questi abbiano fatto di male, ma solo in chiave di punizione, altrettanto arbitraria, dei Giudei che non si sono voluti sottomettere a Babilonia. Del resto si continua a non spiegare perché i Babilonesi vengano premiati, se non interpretando gli altri popoli come marionette per proteggere o punire i Giudei in base ai comportamenti di questi ultimi, peraltro essi stessi arbitrari e uniti solo dal consenso o dissenso rispetto quanto dice Geremia.
A Geremia 46: 8 si ripropone il caso della parola plurale miṣ·rā·yim che regge un verbo al singolare: qui solleva (יַֽעֲלֶ֔ה in Ebraico, ya·‘ă·leh fonetico) al modo di quanto avviene per ‘ê·lō·hîm, parola soggetta a tutto un altro livello di attenzione dal traduttore quando regge un verbo singolare, che qui, come in casi precedenti dove si verifica questa situazione, traduce tranquillamente la parola plurale con il singolare Egitto (miṣ·ray·māh in fonetico) eliminando il problema alla radice.
A Geremia 48: 10 un tranquillo augurio di buona giornata... con la maledizione per chi non intinge la spada nel sangue. Non so se questo punto occorra ancora ricordare l’assurdità della definizione del loro Dio come buono.
A Geremia 49: 31 si ripete, questa volta fedelmente, l’ingiunzione di Yah·weh, già data nel Pentateuco, di marciare contro gente pacifica e ricca, quasi sia il fatto di essere pacifici e ricchi la loro colpa; come perversi criminali odierni che entrano nelle case della gente benestante che non si sia dotata di guardiani. Ciò è conferma del fatto che la guerra di conquista sia stata in effetti portata sulla ‘terra’ da Yah·weh, e per suo tramite, o giustificazione, dagli Israeliti, per diventare poi pratica comune di tutte le nazioni.
Sempre sulla base della sola ‘colpa’ di essere pacifici si scatena l’ira funesta di Yah·weh su Elam, salvo poi, grazie a un’aggiunta assai probabilmente posticcia e alla traduzione creativa di ‘a·ḥă·rîṯ, pronosticare in Geremia 49: 39 una salvezza forse nei giorni del Redentore; non so davvero come possano i monoteisti cristiani interpretare questo brano per salvaguardare l’illusione del Dio buono e misericordioso con gli umili.
E finalmente a Geremia 50: 2-3 la maledizione arriva anche su Babilonia, finora risparmiata, anzi protetta. Con questo il misericordioso Geremia ha maledetto tutto il mondo antico a lui conosciuto...!
Il brano a Geremia 50: 24 lascia davvero perplessi, ovviamente se l’autore è lo stesso, cosa peraltro dubbia. Per il resto del libro si è “sperticato” per tessere le lodi a Babilonia, fino al punto di punire chi non apriva loro le porte o li abbandonava e ora, le si rimprovera di impegnarsi contro Yah·weh, tanto da sottoporli alla sequenza di castighi usuali già riservati ad altri popoli. La ovvia spiegazione alternativa è che i giudizi vengano attribuiti ex post rispetto l’effettivo risultato militare in modo da farlo corrispondere all’ira di Yah·weh.
Poco dopo a Geremia 50: 25 c’è un aspetto bizzarro, se gli autori dell’Uomo d’Acciaio non fossero essi stessi ebrei e non avessero chiamato i loro eroi con l’appellativo ‘el (Kal-el, Jor-el ecc.): infatti udendo “questo è un lavoro per”, non può non venire in mente Superman!
Il verso a Geremia 50: 40 è assai interessante per due ordine di motivi. Il primo è che Yah·weh attribuisce la distruzione di Sodoma e Gomorra a ‘ĕ·lō·hîm, la usuale traduzione con Signore e Dio non cambia radicalmente la questione. Ovviamente se l’ente che parla è quello che ha distrutto le città fosse stato lo stesso, avrebbe usato la prima persona singolare piuttosto che un soggetto alternativo. Ovviamente l’abitudine del lettore identifica Dio con Signore ed è portata a pensare sia piuttosto un artificio retorico. Il secondo è il ripetersi della dicotomia tra ’îš e figli di ‘ā·ḏām, davvero qualsiasi cosa questa possa significare: il traduttore monoteista naturalmente nasconde il problema con sinonimi.
Geremia 52 si presenta alla fine al di fuori delle parole di Geremia, curiosamente riprendendo gli episodi relativi alla caduta di Gerusalemme per mano dei Babilonesi, depurati dei festeggiamenti per gli invasori da parte di Geremia stesso! Il brano con molte probabilità è stato aggiunto successivamente, anche fornendo il dettaglio dell’assedio di Gerusalemme, assente nel resoconto nella prima parte del libro.