[Download] "Bibbia Traduzione Letterale: Isaia" by Fabrizio Bartolomucci * eBook PDF Kindle ePub Free
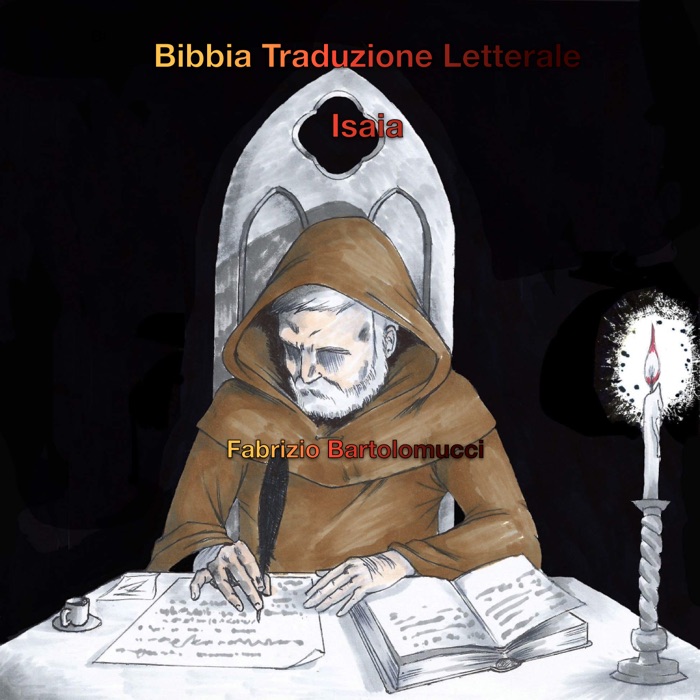
eBook details
- Title: Bibbia Traduzione Letterale: Isaia
- Author : Fabrizio Bartolomucci
- Release Date : January 16, 2017
- Genre: Bible Studies,Books,Religion & Spirituality,
- Pages : * pages
- Size : 17027 KB
Description
Caso quasi unico nella letteratura mondiale, la Bibbia non è mai riuscita a separare la fase della traduzione da quella dell’interpretazione. Probabilmente per l’ambiguità e per la mutabilità del contenuto, da sempre i traduttori hanno provveduto a inserire la loro interpretazione del testo spacciandola per autentica, non disturbandosi di riportare le proprie scelte interpretative, ma piuttosto aggiungendo note che allontanano ancora di più il significato dal testo originale: è caratteristica in ambito cristiano l’iniezione di contenuti del nuovo testamento o addirittura di speculazione teologiche successive come lo spirito santo o le profezie. In questa opera, seguendo le indicazioni di Mauro Biglino, provvediamo invece a tradurre la Bibbia letteralmente, annotando quando si sono fatte scelte diverse: per ‘Ĕ·lō·hîm, e benedire. La struttura di base del testo, per quanto riguarda le parti standard, viene dal portale laparola.net, mentre i contenuti letterali, integrazioni ed emendamenti al testo attingono alla Bibbia interlineare su Biblehub.com. La regola generale per i termini non standard è che, ove una parola ebraica è presente in una singola istanza, oppure in parti diverse con significati diversi, o ancora nel caso che una qualsiasi traduzione potrebbe introdurre nel lettore un bias indesiderato, la decisione è quella di lasciare la parola nell’originale fonetico. Questo è il caso ad esempio di: ‘Ĕ·lō·hîm, Yah·weh, Šad·day, ‘El·yō·wn, Rū·aḥ, Kā·ḇō·wḏ, Mal·’aḵ.
Le persone di nomi, aggettivi e verbi seguono scrupolosamente l’originale ebraico, anche riguardo termini controversi come ‘Ĕ·lō·hîm, Šad·day, ’Êl, senza risolvere arbitrariamente le contraddizioni. Il genere degli articoli e aggettivi resi in ebraico viene associato al genere del termine ebraico, e non a quello di una delle traduzioni in italiano; questo può naturalmente portare a ulteriori discrepanze del testo rispetto le traduzioni clericali. Nel caso particolare di ‘ĕ·lō·hîm, quando preceduto da articolo determinativo, si è deciso di renderlo sempre come ‘gli ‘ĕ·lō·hîm’, anche quando il termine regge un verbo al singolare. La soluzione appare altrettanto insoddisfacente quanto coniugare l’articolo col verbo, in cui si usa l’aggettivo singolare solo con il verbo al singolare, in ‘l’‘ĕ·lō·hîm’, e in tutti gli alti casi al plurale, ma riteniamo la forma decisa preferibile dal punto di vista della leggibilità e obiettività.
Il Libro di Isaia (ebraico ישעיהו, ysha'ihàu; greco Ησαΐας, esaìas; latino Isaias) è un testo contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e cristiana in tutte le tradizioni.
È scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la redazione definitiva del libro è avvenuta in Giudea nel V secolo a.C. ad opera di un autore ignoto, sulla base di maledizioni e testi precedenti di diversa origine:
Proto-Isaia (capp. 1–39): ca. 740-700 a.C. durante il ministero del profeta Isaia, in particolare nel contesto della guerra siro-efraimitica, esortazioni alla fiducia in Dio, trascendente e fedele;
Deutero-Isaia (capp. 40–55): 550-539 a.C., durante l'Esilio di Babilonia, esortazione al popolo oppresso, il "Servo di Yah·weh";
Trito-Isaia (capp. 56–66): 537-520 a.C. dopo il ritorno dall'esilio, maledizioni contro l'idolatria, speranza nella conversione delle nazioni pagane.
Il testo attribuito a Isaia è composto da un numero di profezie a brevissimo termine che hanno spesso acquisito vita propria. Non accettabile quindi la resa come presente o passato per i verbi delle traduzioni classiche in quanto non si tratta assolutamente di cronaca, anche nei rari casi nei quali il testo ebraico usa il tempo presente o ancora più raramente il passato. Naturalmente a parte quando l’autore riporta, spesso magnificandoli, gli eventi del passato auspicando che si ripetano. Questo testo riporta fedelmente il tempo del testo ebraico.
Oltre alla famosa profezia fasulla a cui ha abboccato l’evangelista Matteo sulla “Vergine che concepirà e partorirà un bambino”, senza essere vergine, ma essendo piuttosto già incinta... in Isaia 7:14, c’è la straordinaria invenzione dell’episodio di Lucifero precipitato dal cielo agli Inferi mediante l’estrapolazione dal contesto di Isaia 14:12-15, quando si vede nel resto del capitolo che l’oggetto della parabola è sempre il re di Babilonia. Da notare inoltre, nell’episodio che ha tratto in inganno l’evangelista, che עַלְמָ֗ה è persino preceduta, in forma relativamente rara in ebraico, dall’articolo determinativo הָ, spesso usato per indicare qualcosa di specifico e presente, come in Italiano, del resto e che הָרָ֖ה non è per nulla un verbo, tantomeno al futuro, quanto un avverbio che in Isaia 26:17 viene addirittura usato come predicato.
In altri luoghi, ovviamente meno valorizzati dal monoteista, come in Isaia 4: 5 e Isaia 10: 16 si fa riferimento alle tecnologie antiche in modo ancora piuttosto vivido, auspicandone il ritorno.
Poi in Isaia 13: 13 c’è la curiosa ed evidentemente avventata promessa del redattore di lui stesso operare prodigi, con la auspicata assistenza di Yahweh a cui nel mito si attribuiscono poteri che nemmeno si sognava come togliere la terra dalla sua orbita; passando si nota come il fatto che la terra non fosse al centro dell’universo - tanto da poter essere addirittura spostata! - manifesta come questa credenza, che ha creato tanti problemi millenni dopo a Galileo Galileo, non fosse ancora presente quando questi scritti sono stati redatti.
Buona parte del testo è costituita da maledizioni indirizzate ai nemici del popolo di Israele del tempo, partendo ovviamente dagli odiati Babilonesi, lo sfracello dei figli dei quali essendo stato già indicato come un delizia in brani precedenti, per passare ai Moabiti, Damasco, probabilmente Numidia, Egitto e altri.
Tra queste il simpatico trattamento invocato a Tiro in Isaia 23: 17-18 dove si prefigge di aspettare settanta anni dopo la distruzione per farla riprenderla e poi requisirgli tutti i beni: da questo brano si evince l’origine dei comportamenti predatori, ma anche la vera natura del termine qō·ḏeš, usualmente e anche in questo brano tradotto con sacro, in realtà da intendere come requisizione di beni con la forza.
Il lettore attento può verificare nei libri precedenti, cronologicamente successivi a questo libro, quante poche di tali maledizioni abbiano avuto effetto.
Tra queste risulta particolarmente rilevante la seconda parte del capitolo 19 Isaia 19:18-25 dove spunta un decisamente inedito spirito ecumenico nei confronti dell’Egitto e dell’Assiria che non si trova in nessun’altra parte della Bibbia, né tantomeno nella cultura ebraica contemporanea. Particolarmente enigmatica la parte finale del testo dove si dice, accanto alla ripetizione del fatto che Israele sia l’eredità di Yah·weh, che gli Egiziani siano il suo popolo e addirittura l’Assiria opera delle sue mani, forse per suggerire un’idea stimolante su dove il gan-eden fosse stato installato.
Poi a Isaia 24: 21 un simpatico quadretto in cui si aspetta da Yah·weh che combatta prima i suoi colleghi in cielo, evidentemente ostili al popolo di Yiś·rā·’êl, e poi i re.
In Isaia 25: 8-10 un testo che sarà di sicuro valorizzato dai monoteisti, se si interrompe giudiziosamente la lettura al paragrafo 9, in quanto dal 10 in poi si capisce contro quale minaccia concreta si invochi l’aiuto!
In Isaia 34: 6, per quanto sia orrida la scena del massacro di animali, stridente è il passaggio rispetto i versi precedenti e successivi in cui si annunciano massacri immani con la spada insanguinata non certo dai reni grassi dei montoni. Dopo questo verso e il successivo, in effetti si riprende il tono apocalittico e iettatorio tipico di questo libro, lasciando il traduttore e probabilmente il lettore a domandarsi chi, quando e perché sia stato inserito questo verso, per così dire addolcito, che richiama i sacrifici e per un attimo fa pensare che si domandi a Yah·weh di scaricare la sua ira contro gli animali, piuttosto che contro le popolazioni, come risulta manifesto nel resto del capitolo e della maggior parte del libro.
Dal paragrafo 36 il libro si trasforma per un poco in ancora una nuova riproposizione dei fatti descritti nei libri dei Re, a volte usando le stesse parole.
Tra questi resoconti, memorabile la risposta di Ezechia ai vaticini funesti per il futuro in Isaia 39: 8 nello spirito del predicatore di Ecclesiaste.
Poi dal paragrafo 40 si ricomincia con i vaticini e le maledizioni inframmezzati da ricordi di eventi passati, a volte estesi oltre la loro stessa realtà documentata, come auspicio per una loro riproposizione nel futuro.
In Isaia 42: 5 è presente un curioso appellativo di Yah·weh: al posto di ’ă-ḏō-nāy, tranquillamente tradotto come “il signore”, compare ‘el; se l’autore non sbaglia, l’unica volta nella Bibbia che i due termini siano associati.
In Isaia 45: 7 risulta chiaro come Yah·weh, si identifichi o meno con Dio, si arroghi la qualità di fare la luce e le tenebre, la pace e il male, utilizzando peraltro due verbi distinti per le due cose, quasi a dire che si attribuisce maggiore titolarità per le tenebre e il male che per la lue e la pace, utilizzando per le prime qualità il verbo/sostantivo ḇō·w·rê che viene usualmente tradotto come creatore, a differenza delle altre qualità.
Il paragrafo 50 termina in modo piuttosto schizofrenico: come si vede a Isaia 50: 10-11, prima si manifestano i vantaggi di seguire Yah·weh, poi si torna immediatamente a minacciare sciagure, senza cambiare soggetto o addurre alcuna spiegazione, o in alternativa si consiglia di non accendere fuochi, quale guardia forestale ante litteram... Certo al teologo monoteista non mancheranno argomenti per spiegare il passo dando significati opportuni al fuoco e alle scintille: ipotizzo il fuoco come peccato e le scintille come tentazioni, oppure il fuoco come il demonio e le scintille i suoi diavoli, o ancora il Cristo e i suoi martiri, ma di certo non mancheranno interi libri dedicati solo a questo brano di autori assai più creativi del vostro modesto traduttore.
Poi Isaia 53 si presenta davvero in modo misterioso, probabilmente la più seria profezia per l’avvento di un povero Cristo che i da tanto da fare per poi prendersi la colpa di tutti. Certamente il teologo monoteista non può far altro che attribuirla a Gesù, ma quanti di noi del nostro mondo potrebbero attribuire la profezia alla propri stessa vita?!
A Isaia 55: 5 una nuova prova della non ferrea attenzione del redattore ebraico nel coordinare il numero dei nomi con il verbo. In questo verso il singolare nazione (גּ֤וֹי) regge ben due verbi al plurale: יְדָע֖וּ e יָר֑וּצוּ. Tanto è che, per non far concentrare una pericolosa attenzione sui famosi verbi singolari associati al plurale ‘ĕ·lō·hîm, il traduttore monoteista rende come nazioni, letteralmente inventandosi la forma plurale del termine: גּוֹיִ֔ם. Peraltro al verso successivo ancora una forma curiosa dove sembra che Yah·weh e il ‘Santo’ di Israele siano due oggetti diversi, tanto da essere divisi da una congiunzione. Per non sollevare pericolosi interrogativi, il traduttore monoteista si fa un bel boccone della congiunzione per far diventare la seconda parte un’apposizione della prima; e dire che sulla congiunzione nella profezia sulla nascita di Emanuele si costruisce la verginità della madonna, passando tranquillamente sopra ad avverbi che diventano verbi, e a ragazze che tornano vergini. Peraltro la curiosa congiunzione, questa volta non mitigata nemmeno dal traduttore monoteista, compare al verso 7, tra Yah·weh e il ‘nostro ‘ĕ·lō·hê’, quasi si tratti di due persone diverse.
Se ne sentisse la mancanza, a Isaia 58: 1, si ripresenta l’uso del singolare come collettivo, questa volta non in relazione al verbo, ma ai pronomi personali associati a due predicati verbali, come al solito privi di particella.
A Isaia 60: 22 appare ancora un volta l’ingenuità del popolo ebraico, che ancora sta aspettando che le promesse di Yahweh siano speditamente applicate. Per quanto oramai l’esercito israeliano abbia sviluppato armamenti tali da rendere persino inutile il sostegno di Yah·weh per le loro guerre, essi continuano pur tuttavia a invocare il suo ritorno, per cosa, davvero non si riesce a capirlo.
In Isaia 61: 9 un nuovo inaspettato plurale che regge il verbo וְנוֹדַ֤ע (sarà conosciuto) al singolare. Naturalmente il traduttore monoteista traduce con il singolare stirpe quando la parola זַרְעָ֔ם (discendenti) è indubitatamente plurale e come tale viene tradotta nel resto della Bibbia.